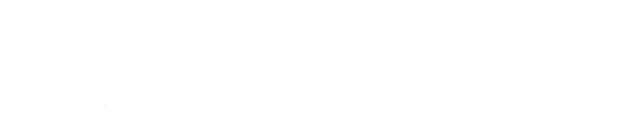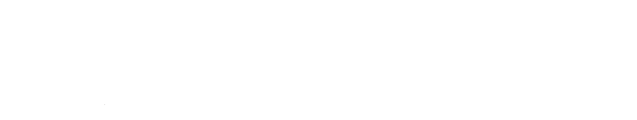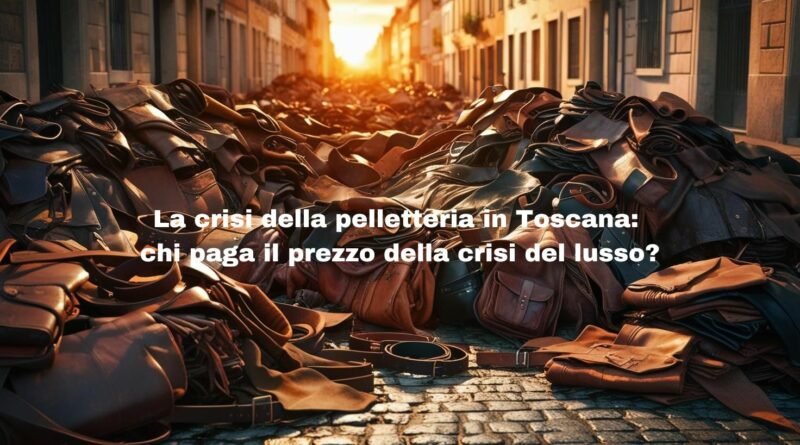
La crisi della pelletteria in Toscana: chi paga il prezzo della crisi del lusso?
Negli ultimi mesi, in Toscana sta accadendo qualcosa di allarmante: il settore della pelletteria, un tempo fiore all’occhiello del Made in Italy, sta crollando. Aziende storiche chiudono, intere filiere vengono smantellate e i lavoratori si trovano senza certezze. Ma di chi è la colpa? E perché nessuno ne parla?
L’evoluzione del lusso: dalle famiglie alle holding
Negli ultimi 30 anni, il mercato del lusso è cambiato radicalmente. Un tempo, brand iconici come Gucci, Fendi, Chanel e Prada erano gestiti da famiglie italiane che ne custodivano tradizione e identità. Con l’inizio degli anni 2000, le grandi holding internazionali hanno iniziato ad acquisire questi marchi, trasformandoli in colossi finanziari. Oggi il settore è dominato da due giganti:
- Gruppo Kering (Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga, Saint Laurent)
- Gruppo LVMH (Louis Vuitton, Fendi, Dior, Céline, Loro Piana)
Con questa trasformazione, anche la produzione ha subito un cambiamento epocale. Se prima le borse, le scarpe e gli accessori venivano realizzati da un’ampia rete di piccoli e medi imprenditori italiani, oggi le holding stanno progressivamente acquisendo fabbriche di proprietà.
L’acquisizione delle fabbriche e il declino della filiera
Il primo a muoversi in questa direzione è stato Kering, che ha acquistato in Toscana tre aziende fondamentali: Toscoval, Pelletteria Annalisa e Garpe. A seguire, Dior, Fendi e Louis Vuitton hanno aperto stabilimenti di proprietà in varie regioni d’Italia, compresa la Toscana e Napoli.
Ma qual è stato l’effetto di queste operazioni? La filiera artigianale si è progressivamente indebolita. Oggi, i grandi brand riducono gli ordini ai terzisti, abbassano le quantità di produzione e accumulano magazzini pieni. Questo porta le piccole e medie imprese al collasso. Il lusso è in crisi e chi ne paga le conseguenze sono proprio quei laboratori e quelle aziende che per decenni hanno costruito il successo del Made in Italy.
Inoltre, la mancanza di nuovi ordini e l’aumento dei costi di produzione hanno reso impossibile per molte aziende mantenere gli standard di qualità che le hanno rese celebri nel mondo. Molte imprese hanno dovuto ridurre il personale o chiudere definitivamente, lasciando migliaia di lavoratori senza un’occupazione.

Il ruolo della politica e la gestione dei fondi pubblici
A questo punto, sorge una domanda cruciale: dove sono le istituzioni?
Non si può dare la colpa ai privati per aver venduto le loro aziende, ma si può e si deve analizzare il ruolo della politica regionale e nazionale nella gestione dei fondi pubblici. Molte delle aziende vendute hanno usufruito di agevolazioni statali, di incentivi e di contributi pubblici con l’obiettivo di creare occupazione e rafforzare il tessuto produttivo. Eppure, non sono stati posti vincoli per evitare la delocalizzazione, i tagli alla filiera e i licenziamenti di massa.
Dove sono le misure di tutela per il comparto manifatturiero? Quali strumenti sta mettendo in campo la politica per garantire la sopravvivenza di un settore così cruciale per l’economia del Paese? La mancanza di risposte e di interventi concreti evidenzia un grave problema di governance e di programmazione industriale.
Perché la crisi del Made in Italy non fa notizia?
In tutto questo, la cosa più grave è il silenzio. Nessuno parla della crisi della pelletteria in Toscana, così come nessuno ha denunciato il taglio dei fornitori in Campania o in altre regioni d’Italia. Mentre i social possono aiutare a diffondere la notizia, la politica e i media tacciono.
La verità è che stiamo assistendo al progressivo smantellamento dell’artigianato italiano, un settore che ha reso celebre il nostro Paese nel mondo. E se non si interviene subito, rischiamo di perdere per sempre un patrimonio fatto di tradizione, competenza e qualità.
Non è solo una questione economica, ma anche culturale: il Made in Italy è un valore che ha bisogno di essere difeso, non svenduto. Il problema non è solo la crisi del lusso, ma il sistema produttivo nel suo complesso, che viene sacrificato per logiche di profitto a breve termine senza una visione di lungo periodo.
Cosa si può fare?
- Chiedere alla politica un intervento concreto, con vincoli per proteggere la produzione italiana.
- Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi della filiera e del Made in Italy.
- Sostenere i produttori italiani, acquistando prodotti realizzati da aziende indipendenti.
- Creare una rete tra gli artigiani e le imprese locali per rafforzare la capacità produttiva e innovativa.
- Promuovere una regolamentazione più stringente per le multinazionali affinché investano davvero nel territorio e non lo depredino.
- Valorizzare il know-how artigianale attraverso percorsi formativi che possano garantire la trasmissione delle competenze alle nuove generazioni.
La Toscana e l’Italia intera non possono permettersi di perdere questo settore. Serve una risposta immediata. Aiutiamo a diffondere la verità sulla crisi della pelletteria e del Made in Italy e a fare pressione affinché le istituzioni finalmente agiscano.
Dimmi cosa ne pensi e condividi questo contenuto.
Con Amore,
Ornella